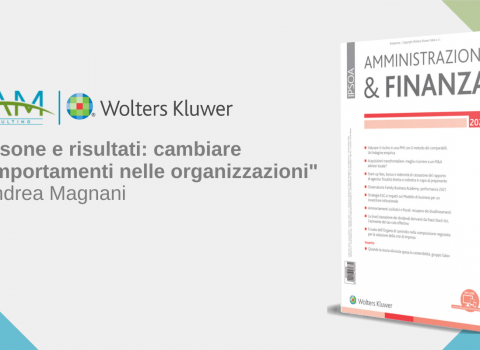- Per info e Contatti
- +39 0547.631068
- info@lamconsulting.it
Neuroscienze e Apprendimento nelle organizzazioni

Lo Sviluppo Commerciale: come migliorare i risultati commerciali
20 Ottobre 2022
Change Management e formazione a pioggia
20 Ottobre 2022Apprendimento e Neuroplasticità
Cominciamo col ribadire un concetto importante che sta, a nostro avviso, alla base dell’apprendimento: lo scopo della formazione non è che le persone partecipino alla formazione, fenomeno misurabile in ore di formazione. E non è nemmeno che le persone siano soddisfatte della formazione; a meno che l’obiettivo della formazione non sia esclusivamente la felicità dei dipendenti; semmai la soddisfazione è qualcosa di desiderabile ma non certamente il fine ultimo. Lo scopo della formazione è quello di generare un cambiamento. Quando vi è apprendimento questo si deve riflettere in un cambiamento, un’evoluzione, un miglioramento, in ciò che le persone fanno. Come sottolineava Lejandro Herrero, il cambiamento non può essere visto come un fenomeno astratto: anche quando parliamo di cambiamento culturale, in realtà ci aspettiamo che i comportamenti delle persone cambino.
Questo è il motivo per cui ci dobbiamo seriamente interessare al fenomeno della neuroplasticità. Quando parliamo di neuroplasticità ci riferiamo al fatto che il nostro cervello si modifica generando nuove possibilità, nuovi schemi motori, nuove associazioni, in sintesi un nuovo apprendimento.
La base dell’apprendimento: come avviene il cambiamento nel nostro cervello
Fino a qualche decennio fa si pensava che il cervello fosse fatto per cambiare nei primi anni di vita per poi rimanere piuttosto inalterato. In realtà il cervello è in continua trasformazione anche in età adulta. Il fatto è che mentre fino ai 20-25 anni è sufficiente rimanere immersi in un ambiante per essere influenzati e modificare i nostri circuiti, da quell’età in poi è necessario che si creino, volontariamente o no, delle precise condizioni neurochimiche.
Perché ci dobbiamo interessare alla biologia dell’apprendimento? Perché se lo facciamo possiamo trarre delle indicazioni molto precise su come amplificare i risultati dei nostri sforzi di apprendimento sia se siamo persone che investono nella propria crescita professionale, sia se ci occupiamo dello sviluppo delle altre persone nella propria organizzazione. E, al contempo, comprenderemo molto chiaramente il motivo per cui la formazione fatta come è sempre stata fatta, serve a ben poco. Vediamo dunque cosa deve avvenire.
Perché il cervello di un adulto si apra alla neuroplasticità serve l’attivazione di due neuromodulatori: l’epinefrina e l’acetilcolina. La prima, altro nome per descrivere la molecola dell’adrenalina, ha la funzione di attivare a livello generale la funzionalità cerebrale. La seconda funge da riflettore che punta focalmente a illuminare l’area del cervello interessata. Detto in altri termini, la neuroplasticità è determinata da un certo livello di attivazione, di stress. Non apprendiamo quando siamo super rilassati. Non a caso invece, se sottoposti ad una forte paura il nostro cervello può apprendere in un batter d’occhio un insieme di nuovi comportamenti che vanno sotto il nome di “Disturbo Post Traumatico da Stress“. Senza raggiungere quegli estremi, sappiamo che memorizziamo più facilmente delle informazioni se le associamo con qualcosa che stimola la nostra attenzione; se si tratta di argomenti che ci emozionano. Vediamo nel dettaglio cosa possiamo fare per generare questo innalzamento del livello di attivazione.
Attivare il sistema simpatico per apprendere
Possiamo sicuramente fare riferimento al fatto che l’attenzione, la nostra capacità di appassionarci delle cose, è la conseguenza di un allenamento. Vi sono poi tecniche mnemoniche che ci consentono di creare associazioni che innalzino il livello di attivazione dei nostri percorsi neurali. Però vi sono aspetti che permettono di agire in modo immediato passando attraverso la via corporea.
Se è vero che la nostra neuroplasticità è stimolata da uno stato di attivazione neurofisiologica, ci sono effettivamente delle cose che possiamo fare e che hanno la capacità di innalzare il livello di adrenalina. Entrambe queste tecniche sono state utilizzate in ricerche scientifiche per misurare la capacità di apprendimento.
- Respirazioni con iperventilazione. Respirare in modo accelerato accentuando l’inspirazione per un breve tempo (20-25 respiri) innalza velocemente il nostro livello di adrenalina. Ovviamente non è da fare se stiamo soffrendo di un attacco di panico. Ma se partiamo da una condizione normale, questa sequenza di respiri aumenta la nostra capacità di focalizzarci.
- Mettere le mani dentro acqua ghiacciata. Va bene, anzi funziona anche meglio, se ci immergiamo con tutto il corpo nell’acqua ghiacciata, ma è sicuramente più difficile da realizzarlo in un ufficio in openspace.
So che se iniziassimo una riunione o una sessione formativa con un ciclo di respiri passeremmo per inguaribili figli dei fiori. Ma se superassimo queste ridicole resistenze da pinguini incravattati ne trarremmo grande beneficio. Adesso però affrontiamo un aspetto che da un punto organizzativo ha una valenza maggiore.
Attivare l’apprendimento attraverso l’errore
Più in generale, possiamo dire che il nostro cervello è disposto a mettere energia per modificare se stesso, quando questa modifica è rilevante. Vi sono particolari segnali che arrivano dall’ambiente che ci possono segnalare che un cambiamento è necessario. Abbiamo fatto l’esempio di una grossa paura, della percezione di un imminente pericolo. Ma più in generale, e ad un livello di stress più contenuto ed accettabile, ci riferiamo all’errore. Se lanciamo un foglio di carta appallottolata dentro un cestino, è proprio l’errore a spingere il nostro cervello a correggere il pattern motorio affinché diventi più affidabile. Se il cestino fosse troppo vicino, centreremmo l’obiettivo ad ogni tiro; in brevissimo tempo la noia sopraggiungerebbe e addio adrenalina. Ma se lo sbagliassimo 7 volte su 10, questo segnalerebbe al nostro cervello che qualcosa non funziona e si attiverebbe un’innata capacità di migliorarsi.
Evitiamo di annuire magari ripetendo meccanicamente: “sbagliando si impara”. Chiediamoci piuttosto qual è quel contesto formativo che include questa esperienza dello sbagliare.
Un corso di public speaking, con 20 partecipanti. La benedetta didattica attiva: ognuno fa una presentazione di 15 minuti con discussione. Nessuna ripetizione. Nessuna esperienza di errore successiva alla prima. Poi arriva il giorno del public speaking vero. Lì non si può sbagliare. O comunque, l’errore di quell’esperienza semmai può predisporre alla neuroplasticità per l’evento successivo. A patto che finito il public speaking ci si fermi a riflettere sugli errori, magari ci si metta a ripetere i punti critici cercando di migliorarli (devo tenere le mani più ferme, devo evitare tutti quei “ehmmmm”, ecc.). Ma normalmente dopo… non c’è mai tempo per queste cose. Ci sarà sicuramente un buffet in cui rimpinzarsi di pizzette e bere prosecco.
L’apprendimento informale: cos’è e come si attiva
Andiamo oltre e lasciamoci alle spalle la vecchia stantia aula formativa – che poi non è che il problema sia risolto piazzando le persone davanti a dei modernissimi video formativi – e occupiamoci del molto più interessante apprendimento informale.
L’apprendimento informale è quello che emerge dalle esperienze lavorative; quando per risolvere un problema dobbiamo imparare ad utilizzare uno strumento; per raggiungere un obiettivo apportiamo più o meno consciamente delle modifiche al nostro operato vedendo quello che otteniamo; oppure guardiamo come fa un nostro collega o ci confrontiamo e generiamo soluzioni in gruppo.
E’ evidente che il potere formativo della quotidianità c’è ed è basato proprio sullo stress generato da un problema o sulla tensione verso un obiettivo. Se pensiamo che questo apprendimento è potenziato dal poter ripetere un errore (e poterlo correggere), ci possiamo chiedere: onestamente, quante sono le realtà aziendali in cui l’errore è davvero ammesso a cuore aperto?
Creare spazi di apprendimento: come strutturare un intervento formativo efficace
L’errore fa parte della vita. Affrontare una sfida ed essere consapevoli di poter fare meglio è parte integrante di qualsiasi vissuto lavorativo. E infatti un apprendimento continuo, sul piano informale, è presente.
Il punto che vogliamo sottolineare è che, la conoscenza della biologia dell’apprendimento ci porta anche a vedere quante occasioni mancate di apprendimento.
Abbiamo detto che l’errore avviene. Ma quante volte le persone si adagiano su quell’abitudine e smettono di percepire che la pallina di carta non sta affatto entrando nel cesto! Possiamo anche pensare che l’attivazione di una cultura del feedback sia utile a illuminare (come fosse acetilcolina prematurata) l’attenzione sull’errore e quindi stimolare un passaggio evolutivo. Ma smettiamola di volare alti sulle grandi e belle intenzioni: quando arriva il feedback? Una volta l’anno? No, perché la cosa che funziona è accorgersi dell’errore quando lo si fa! E quando parliamo invece di ongoing feedback o feedback continuo, pensiamo che le persone siano davvero così responsabilizzate nel dare feedback correttivi precisi e tempestivi? Ma soprattutto c’è un altro limite del contesto lavorativo che lo rende così diverso da un contesto di apprendimento efficace ed efficiente.
Quando incontri il cliente, beh è meglio che non commetti troppi errori. Se stai facendo un report ai referenti del tuo fondo di investimento, anche lì, eviterei di provare le nuove super tecniche di influential communication, andrei sul sicuro con il repertorio di competenze ben consolidate; il nuovo macchinario? Meglio non rischiare di lasciarci due dita. Insomma nei contesti lavorativi non c’è quello che può vivere un pilota d’aerei che può provare a schiantarsi mille volte in un simulatore di volo. O quello spazio che si crea il violinista che prova e riprova ottomila volte, per quattrocento ore, quelle maledette due battute in cui le dita sembrano intrecciarsi: non può farlo quando è sul palco davanti a un pubblico. Queste banali, ma che in ambito organizzativo sono passate completamente sottotraccia, considerazioni, ci hanno portato a sviluppare a partire dal 2009 un metodo chiamato Laboratorio delle competenze. E no, non è coaching. Quello che si fa normalmente nel coaching è un’attività che lavora sul piano cognitivo. Ha altre funzioni. Il laboratorio serve a far sbagliare e ripetere fino all’acquisizione di una competenza.
Andrea Magnani
CEO & Founder di LAM Consulting srl SB